Sono
nato a Marzabotto, nell’Appennino bolognese, il 19 novembre 1930
da famiglia contadina, ultimo di quattordici fratelli figli di
Attilio e Fulvia Paganelli. Nel 1932 per esigenze famigliari,
a Marzabotto non c’era più lavoro, ci siamo trasferiti a Bologna
dove il babbo lavorava come operaio agricolo. Qui ho frequentato
le scuole elementari fino alla seconda poi subito a lavorare come
garzone sempre nel mondo agricolo. Avevo dieci anni nel giugno
1940 quando ho appreso che l’Italia era in guerra. Per me non
è cambiato nulla, lavoro e fatica ogni giorno come sempre. Di
diverso vi era solo che alla sera ascoltavo i discorsi del babbo
e della mamma preoccupati per due dei miei fratelli, uno in fanteria
combattente in Africa e l’altro nei bersaglieri dislocato in Sardegna.
In casa nostra non si è mai fatto politica o meglio le idee del
babbo non erano certamente accondiscendenti con il regime, anzi…..
Agli
inizi del 1943 ho cominciato a sentir parlare e a capire le parole
resistenza, democrazia, libertà, in particolare da mio fratello
Renato il più vicino di età. Con gli avvenimenti legati all’armistizio
dell’8 settembre, Renato ha scelto subito la lotta armata con
la formazione partigiana “Brigata Bianconcini”, ed io, pur essendo
poco più che un ragazzo fra i tredici e i quattordici anni ho
sentito mio dovere mettere in pratica il pensiero politico con
il quale ero stato cresciuto, confidando la mia volontà al babbo.
Come uomo con i suoi ideali non poteva certamente opporsi alla
mia scelta, come padre mi raccomandò le solite cose; stai attento
che non è un gioco. Entravo così nella clandestinità, aiutato
o se vogliamo dire “raccomandato” da mio fratello Renato che mi
convinse a non unirmi a lui nella stessa formazione, in modo da
diminuire la possibilità di essere catturati o uccisi entrambi,
presentandomi a Mario Musolesi comandante della formazione partigiana
“Stella Rossa” che operava nel territorio di Vado, Monte Sole,
Monzuno, nell’Appennino bolognese. Ovviamente per la mia giovane
età non mi lasciavano partecipare ai combattimenti ma venivo utilizzato
come staffetta, ribattezzandomi subito “il balilla”. Man mano
che i mesi passavano le azioni contro i tedeschi si facevano sempre
più cruente con morti e feriti da entrambi le parti. Dopo quasi
un anno di vita in montagna fra staffette e azioni di guerra vere
e proprie, nel settembre 1944 durante uno scontro con i tedeschi
rimasi ferito ad una gamba. Caricato con gli altri feriti venni
trasportato presso un ospedale da campo in località Pieve Santo
Stefano in Toscana dove fui curato e dove rimasi per la convalescenza.
In Toscana si stavano concentrando le forze alleate e reparti
dell’esercito italiano inquadrati nel Corpo Italiano di Liberazione,
ed io e mio fratello, che nel frattempo mi aveva raggiunto, si
ragionava sul da farsi e come continuare la lotta intrapresa.
Infine la decisione, o meglio, riuscii a convincere mio fratello;
lasciamo entrambi la lotta partigiana clandestina e ci arruoliamo
volontari nell’esercito italiano. Nei primi giorni di gennaio
del 1945 dimesso dall’ospedale, sappiamo che a Scarperia è operativo
un campo di smistamento alleato e la ci dirigiamo. Come italiani
veniamo indirizzati presso il comando del Colonnello Galliano
Scarpa comandante del Reggimento Fanteria Speciale “Legnano”.
Dopo un primo momento di imbarazzo dovuto alla mia età, ero minorenne,
ma di fronte alla mia risolutezza, accoglie la nostra richiesta
di arruolamento volontario assegnandoci entrambi alla 108ª compagnia
del Battaglione Alpini “L’Aquila”, mio fratello come autista ed
io quale conducente muli delle salmerie. Qualche giorno dopo ero
vestito in divisa militare con tanto di cappello, penna nera ed
un bel mulo. Non ricordo quale fosse il suo “vero” nome di matricola,
io lo chiamavo “la checca” in onore al mio soprannome “il checco”
diminutivo di Francesco. Forse in quel momento non mi rendevo
esattamente conto cosa significasse veramente essere “Alpino”
ma ben presto ho capito. Mi hanno certamente aiutato i “veci”
reduci della Grecia e della Russia con i loro “racconti” e con
l’esempio della loro “alpinità” vissuta per l’onore delle “fiamme
verdi” e della “penna nera”.
| 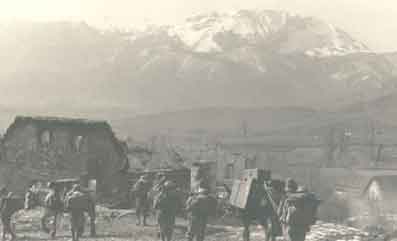
Le salmerie della 108ª
compagnia in marcia dal Passo della Raticosa
verso il fronte
emiliano.
L’ultimo a destra, di spalle, Francesco Ventura.
|
| 
Un momento di sosta della
108ª compagnia durante la marcia verso
la prima
linea.
Al centro sotto la finestra Francesco Ventura.
|
Il
10 di marzo del 1945 ci giunge l’ordine di avanzata per entrare
in linea. Tutto il Reggimento, del quale fanno parte oltre al
Btg. alpini “L’Aquila”, il Btg. alpini “Piemonte”, il Btg. Bersaglieri
“Goito”, 2 compagnie mortai, 3 compagnie armi accompagnamento
e 4 compagnie comando e servizi, è in marcia per la direttrice
Scarperia, Passo della Raticosa, Monghidoro, La Martina, Cà del
Vento, Parrocchia di Vignale, Montecorona. Il mio battaglione
viene dislocato a Montecorona; siamo in linea! Poi di nuovo avanti
per la Valle Idice oltrepassando Monterenzio fino alla delicata
e strategica località Cà di Bazzone dominata dall’alto da una
forte posizione nemica. Qui il 23 marzo durante una pattuglia
per esaminare la possibilità di strappare quella quota al nemico,
cade eroicamente il nostro comandante di Battaglione, Maggiore
Augusto de Cobelli, che verrà decorato di medaglia d’oro al valor
militare. Finalmente il 10 aprile un nuovo ordine; avanzare a
tutti i costi, direttrice Bologna! Possiamo finalmente vendicare
il nostro Magg. De Cobelli. Occorrono dieci giorni prima di arrivare
a Bologna, dieci giorni di aspri combattimenti ma anche di decisa
volontà. Sappiamo che il nostro fratello Btg. alpini “Piemonte”,
al quale è stata assegnata un’altra direttrice, ha l’ordine di
raggiungere Bologna nella mattina del 21 aprile, ed infatti alle
ore 6 giunge a Porta Santo Stefano per sfilare poi nel centro
della città. Il Btg. alpini “L’Aquila” ha invece l’ordine di retroguardia,
infatti la nostra direttrice è la Via Emilia. Entriamo nella periferia
di Bologna nella zona del quartiere San Donato alle ore 6 del
pomeriggio. Le salmerie ed i muli vengono sistemati nelle scuole
“Giulio Giordani” che sono a cento-centocinquanta metri da casa
mia. La nostalgia di casa è forte, desideravo tanto poter abbracciare
e tranquillizzare babbo e mamma che non sapevano che ero così
vicino. Non è possibile! Devo consegnare il mio mulo in quanto
giunge l’ordine di ripartire subito. E’ notte inoltrata quando
tutto il battaglione compresi i 4 pezzi (i cari 75/13 dell’artiglieria
alpina) è caricato sui camion, senza le cucine campali a seguito
ma solo con i viveri da combattimento individuali, partiamo. Dopo
due giorni si giunge a Ponte di Legno dove siamo destinati di
presidio. La mia compagnia, la 108ª, viene poi dislocata al Passo
del Tonale per rastrellare e disarmare i numerosi sbandati tedeschi
presenti in Val Camonica. Ai primi di giugno cominciano ad arrivare
i primi fonogrammi con l’ordine di smobilitazione dei “volontari”.
Vengo chiamato a rapporto dal Col. Galliano Scarpa, comandante
del Reggimento, che dopo brevi convenevoli mi pone due possibilità:
o subito a casa in congedo per poi essere chiamato con la leva
della classe 1928 per fare i 18 mesi previsti o continuare la
naja ed in questo caso saranno conteggiati i mesi già svolti.
Sinceramente ero in serio imbarazzo, la nostalgia di casa era
molto forte e non sapevo decidermi, allora il Col. Scarpa che
leggeva il tentennamento della scelta, paternamente mi disse;
se tu fossi mio figlio ti consiglierei di toglierti il pensiero
subito continuando la naja. Se ti confermi questa è una licenza
senza data di rientro al reparto, vai a casa, saluta i tuoi, riposati
poi ritorni presentandoti a Tarvisio. Era un atto di fiducia che
non potevo non accettare. Sono passato in fureria dove ho ritirato
la licenza e la “decade” più gli arretrati, era una bella somma.
Dopo circa un mese di licenza dove ho cercato di vivere anche
gli arretrati, la bella somma era praticamente finita anche perché,
da figlio rispettoso, buona parte era stata messa a disposizione
in casa. Sono “in bolletta”, decido di partire, ed ai primi di
luglio mi sono presentato nella caserma di Tarvisio dove era in
fase di rinascita il nuovo Btg. Alpini “L’Aquila”. Sono stato
nuovamente assegnato alla mia vecchia compagnia, la 108ª, formata
ora nella quasi totalità da giovani chiamati di leva, ed essendo
il più “anziano” di servizio sono stato subito promosso caporale
ed il mese successivo caporalmaggiore. Qui sono rimasto fino alla
fine di settembre 1945 poi col reparto ci siamo trasferiti nella
nuova sede a Conegliano. Col 1° gennaio 1946 sono stato promosso
sergente con incarico di sottufficiale addetto alle salmerie della
108ª compagnia del Btg. Alpini “L’Aquila” dell’8° Reggimento Alpini
e alla fine di luglio sono stato congedato con la nomina a sergente
maggiore.
Avevo
concluso il mio servizio alla Patria ed ero fiero della mia appartenenza
ad un glorioso reparto alpino. Il 25 maggio 1950 sono stato chiamato alla visita di leva con la classe 1930 ed avendo presentato la documentazione rilasciatami dal comando del Btg. Alpini "L'Aquila" che attestava il mio "servizo militare come volontario" già svolto, sono stato lasciato in congedo provvisorio in attesa di verifica da parte dell'autorità militare. Il 4 febbraio 1952 sono stato ammesso al rinvio di eventuale chiamata alle armi in epoca da determinarsi. Finalmente il 25 maggio 1953 mi è arrivata la dispensa alla ferma di leva, ed iscritto nella forza in congedo del Distretto Militare.